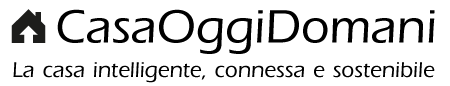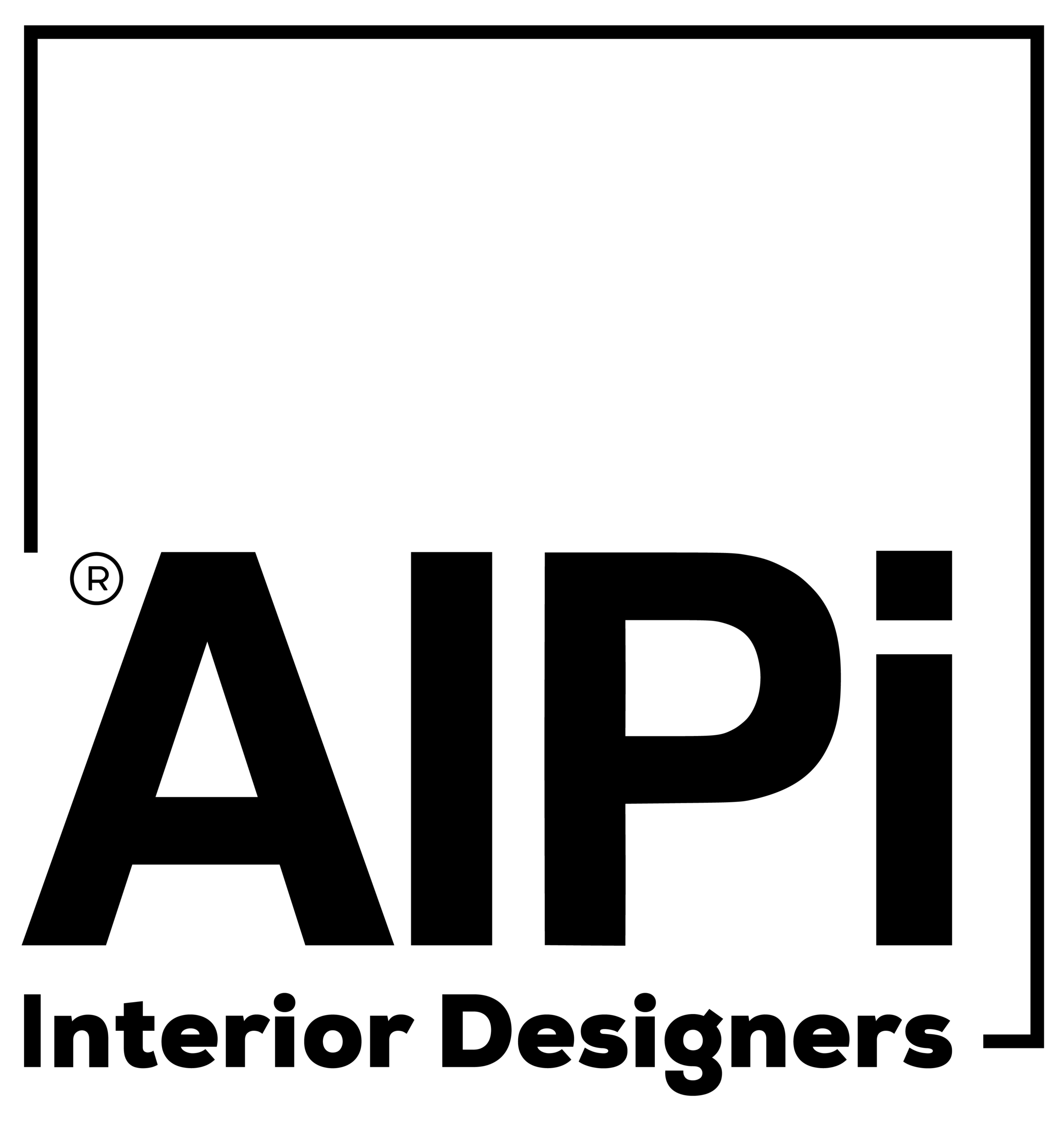Negli ultimi decenni nel settore edilizio e nella concezione stessa di casa, siamo passati dal marketing del “chiavi in mano”, all’integralismo del “fatto su misura”, “sartoriale”. Sono risposte del mercato al cambiamento sociale, riflessi di nuovi bisogni, sia in architettura che nel comparto arredo e design. Adesso i progettisti ci invitano ad una nuova riflessione, una visione più ampia che, come un grande insieme, sembra comprenderle tutte e offrire una soluzione unica a tanti dubbi su come costruire un ideale contesto abitativo. Ma soprattutto un approccio che obbedisce a quel desiderio insito in ciascun individuo al momento di progettare il proprio spazio abitativo: l’aspirazione al “per sempre”.
Negli ultimi decenni nel settore edilizio e nella concezione stessa di casa, siamo passati dal marketing del “chiavi in mano”, all’integralismo del “fatto su misura”, “sartoriale”. Sono risposte del mercato al cambiamento sociale, riflessi di nuovi bisogni, sia in architettura che nel comparto arredo e design. Adesso i progettisti ci invitano ad una nuova riflessione, una visione più ampia che, come un grande insieme, sembra comprenderle tutte e offrire una soluzione unica a tanti dubbi su come costruire un ideale contesto abitativo. Ma soprattutto un approccio che obbedisce a quel desiderio insito in ciascun individuo al momento di progettare il proprio spazio abitativo: l’aspirazione al “per sempre”.
I progettisti contemporanei ci informano che per garantire vita lunga a una struttura residenziale è indispensabile costruire un “progetto aperto”, fare largo al concetto di “incompiuto”, un metodo, insomma, in grado prevedere trasformazioni più o meno imminenti nel tempo e in grado di lasciare spazio ai mutamenti – ponte tra presente e futuro. I più fortunati e saggi hanno sperimentato tali ponti in abitazioni storiche che hanno ristrutturato in maniera filologica e quindi lasciando che lo spirito originale dello spazio continuasse ad aleggiare anche nella rinnovata versione.
Il rischio della rigidità e perché la casa incompiuta è anche etica
Molto spesso l’aspettativa è: “voglio una casa che non richieda più interventi”, “la voglio perfetta da subito”. Ma tale approccio può generare ambienti rigidi, che diventano obsoleti al mutare delle esigenze, delle abitudini, della composizione familiare; ma anche sprechi di demolizioni, rifacimenti, cambio di finiture, consumi energetici derivanti dall’inserimento di sistemi che non prevedono flessibilità.
E, non ultimo, un rapporto statico tra abitante e spazio: la casa diventa luogo di consumo più che di trasformazione. Se invece pensiamo la casa come processo, come “campo di possibilità”, allora si apre un orizzonte più sostenibile: spazi che accolgono cambiamento, che l’abitante può completare o trasformare nel tempo, senza dover demolire o rifare tutto. Un approccio che abbraccia la durata, l’evoluzione, il divenire.

Case history – Pierattelli Architetture
A Como, un appartamento di 300 mq su quattro piani, affacciato sul lago, è stato trasformato dallo studio Pierattelli Architetture in una dimora elegante e armoniosa, dove architettura e natura dialogano con equilibrio. Il progetto unisce funzionalità quotidiana e atmosfera vacanziera, valorizzando la luce naturale, i materiali caldi e le tonalità neutre.
Gli spazi si aprono verso l’esterno con una grande vetrata che collega la zona giorno a una terrazza con piscina e area relax, creando continuità tra interno ed esterno. Gli interni alternano boiserie in rovere, marmo e ottone naturale, arredi d’autore e opere d’arte scelte insieme ai proprietari. Ogni livello ha una funzione precisa, dalla palestra al piano terra fino alla “Cigar Room” panoramica all’ultimo piano, ma il percorso è fluido e coerente. L’intervento riflette la filosofia dello studio: un design essenziale, funzionale e senza tempo, dove la casa diventa un luogo intimo, capace di raccontare chi la abita e di accogliere il silenzio, la luce, il paesaggio come elementi architettonici e ovviamente i mutamenti.
Alcuni scorci dell’abitazione su quattro pani progettata a Como da Pierattelli Architetture
“Per noi progettare in modo “aperto” significa avere il coraggio di plasmare uno spazio che non abbia una forma definitiva, ma di predisporlo a trasformazioni future”, spiega l’architetto Claudio Pierattelli. “È un atteggiamento che mette al centro chi abiterà il luogo, che serve a dare una risposta ai bisogni che cambiano. Per noi l’architettura deve potere accogliere le varie necessità degli abitanti senza demolizioni o sprechi di risorse. Nel progetto della Casa al Lago di Como abbiamo lavorato proprio seguendo questa idea. Importante per noi è partire da una preesistenza, rispettarne la memoria, e al tempo stesso predisporre gli spazi a futuri innesti, per esempio l’inserimento di opere d’arte. In questo senso l’architettura diventa un organismo vivo, capace di evolvere”.

Perché “abitare” come giardino
Pensare la casa come un giardino significa considerarla come un organismo che cresce, cambia, si adatta. Ma come si può applicare questo approccio all’interno del contesto abitativo? Ecco alcuni suggerimenti:
- prevedere elementi che possono essere lasciati “grezzi” o “in evoluzione” (non tutto deve essere definito al millimetro al termine del cantiere);
- lasciare riserve spaziali o strutturali: stanze “di riserva”, volumi da attrezzare o da collegare in un secondo momento;
- permettere all’abitante di partecipare al completamento: scelta di finiture successive, arredi trasformabili, partizioni interne che possono evolvere;
- utilizzare materiali e sistemi che non precludano varianti: ad esempio, pareti mobili, sliding panels, finiture modulabili, impianti predisposti;
- ridurre gli sprechi: in luogo di demolizioni, pensare all’“aggiunta” o alla “trasformazione”.
Un progetto che nasce rigido, “chiuso”, rischia di diventare obsoleto o di costringere a interventi invasivi; un progetto modulare o “aperto” invece accoglie la vita che si fa, ridefinisce la casa come “laboratorio” o “ecosistema domestico”.
Case history – Agriturismo Corte Pravecchio: Rural Urban con Carl Hansen & Søn
Nell’applicazione dell’approccio “casa uguale giardino”, una funzione molto importante è quella degli arredi: se selezionati con criterio permettono di avere un ambiente “aperto, da coltivare”.
Un esempio è l’agriturismo Corte Pravecchio, progettata dallo studio Rural Urban, con elementi d’arredo firmati Carl Hansen & Søn: “Siamo lieti di essere stati scelti dallo studio di design Rural Urban per il progetto di interior dell’agriturismo Corte Pravecchio” afferma Stefano Alberzoni Area Manager South Europe & Middle East Carl Hansen & Søn. “Ogni progetto rappresenta un’opportunità unica per creare ambienti che raccontano storie, emozioni e tradizioni. Lo stile Carl Hansen & Søn incarna la tipica quiet elegance danese: una raffinatezza discreta, fatta di linee sobrie, proporzioni armoniche e materiali naturali, pensata per durare nel tempo e per integrarsi con ogni contesto. In particolare, Corte Pravecchio è un luogo speciale: un antico casale risalente al XVII secolo che convive armoniosamente con una nuova ala, dedicata alle sei suite.
Gli elementi d’arredo firmati svolgono qui un ruolo fondamentale: diventano il filo conduttore che mette in dialogo le due anime della struttura, valorizzando il fascino storico del casale e, al tempo stesso, definendo l’identità contemporanea dell’agriturismo. Gli elementi di arredo selezionati sono studiati per integrarsi con ogni spazio, creando continuità tra passato e presente. La sala da pranzo, cuore pulsante della struttura, è arricchita dall’iconico set di sedie CH24.
Nelle suite le sedie CH24, Cuba chair MG501 e i divani Sideways RF1903 definiscono aree relax intime e accoglienti, dove ogni ospite può vivere un’esperienza di quiete e armonia. Anche negli spazi esterni, le sedie AH501 abbinate ai tavoli AH902 consolidano il legame tra interno ed esterno, tra architettura storica e nuovi ambienti. In questo progetto, ogni elemento d’arredo diventa non solo funzionale, ma anche narrativo: un ponte che unisce storia e contemporaneità.”


Linee guida per il progettista (e per il committente)
Se assumiamo che vogliamo una casa che duri, che evolva, che lasci spazio alla crescita, non solo alla consegna finita, possiamo individuare alcune linee guida progettuali: predisposizione invece di definizione totale, ovvero lasciare alcune zone “in bianco” (non completate completamente) con finiture che possano essere mutate o integrate in seguito; struttura vs finitura, in altre parole garantire la qualità della struttura e dell’involucro (impianti principali, apertura, orientamento, flussi) e lasciare che le finiture interne (pareti mobili, pannelli, arredo) possano evolvere.

Fondamentale è poi la modularità / trasformabilità, pensare a spazi che possano “aprire” o “chiudere” funzioni, ad esempio salotto‑studio che potrà diventare camera ospiti, oppure kitchenette che potrà trasformarsi in home‑office. E quindi la predisposizione impiantistica e infrastrutturale deve essere il riflesso di questo disegno, quindi prevedere cablaggi, percorsi, predisposizioni per future estensioni o cambiamenti senza dover rifare tutto. C’è poi l’uso di materiali adattabili / sostenibili, materiali che possano essere modificati, smontati, riciclati (evitare finiture che vincolino rigidamente l’uso).
Per il committente è fondamentale, invece cambiare la mentalità:
- accettare l’imperfezione temporanea, una casa che cresce può non essere “perfetta” da subito in ogni dettaglio, ma sarà più adatta nel tempo;
- vedere la casa come investimento a lungo termine, non solo nella durata fisica, ma nella capacità di adattarsi, quindi di evitare costosi ripensamenti;
- collaborare con l’architetto in una prospettiva evolutiva, non solo “questa sarà la planimetria definitiva”, ma “questa è la struttura, queste sono le possibilità che possiamo progettare insieme”;
- abitare e sperimentare, quindi lasciarsi spazio per provare, cambiare, modificare, la casa non è un museo, è un luogo vivo.

The Da House (dello studio polacco Dom Architektów)
The Da House (dello studio polacco Dom Architektów) è un innovativo oggetto modulare realizzato con legno massiccio certificato in costruzione 3D, interni in legno, materiali ecologici certificati, tecnologia passiva e fondazioni mobili. Questa abitazione combina la semplicità e la qualità della costruzione prefabbricata con la bellezza e l’integrità di un oggetto altamente estetico.
I criteri principali sono stati: materiali naturali e riciclabili, standard di efficienza energetica molto elevati, risparmio idrico e riduzione dell’impronta di carbonio durante l’intero ciclo di vita dell’edificio. Sono stati utilizzati legno e materiali facilmente riciclabili, e l’attenzione all’impronta di carbonio del progetto è integrata in tutto il ciclo di vita delle case modulari DA.
L’edificio modulare Da House è stato realizzato nella fabbrica artigianale Da secondo la propria tecnologia “modulo in legno massiccio”, che prevede la prefabbricazione dell’edificio sotto forma di moduli tridimensionali in legno, senza l’impiego di acciaio. La struttura e le partizioni interne sono realizzate in legno e materiali derivati dal legno, senza l’uso di pellicole barriera al vapore. Abbracciando un’innovativa mobilità, un edificio composto da moduli può essere trasportato in qualsiasi luogo, e anche le sue fondazioni sono mobili. Tutti i materiali sono riciclabili, e la costruzione di questa struttura ecologica è il risultato di diversi anni di preparazione teorica e pratica.

La casa “aperta” e in continua trasformazione agli ultimi eventi dedicati all’abitare
Il panorama attuale ci lancia costantemente questo messaggio dal sapore new age, un messaggio che talvolta assomiglia a una provocazione ma che in realtà ha l’obiettivo di sensibilizzarci su una nuova visone di progetto abitativo. Come è avvenuto negli ultimi eventi dedicati al design. Il tema della sedicesima edizione di Venice Design Week (VDW), 11 – 19 ottobre, è stato proprio “Tempora”, a designare un ponte tra passato e futuro, un luogo d’incontro tra epoche, culture e saperi.
Il design diventa così un processo fluido e collettivo, dove l’energia del cambiamento nasce dall’incontro tra tradizione, innovazione e diversità. In questo contesto, il design supera la dimensione individuale per trasformarsi in un racconto condiviso: dialoga con la natura, con le tecnologie in evoluzione e con le comunità. Ogni progetto si inserisce in un flusso che valorizza la memoria, guarda al futuro e promuove la sostenibilità.

Alla Milano Arch Week 2025, MAB Arquitectura celebra vent’anni di attività con la mostra “Positivo e Negativo”, un’esposizione che esplora il sottile equilibrio tra pieni e vuoti, cuore della loro riflessione progettuale, che invita i visitatori a interrogarsi su “Che ruolo ha il vuoto in architettura?”. E in occasione di EDIT Napoli 2025 (10 – 12 ottobre) un progetto di Elena Salmistraro, che reinterpreta il modulo abitativo HouseTree di Paolo Scoglio (The Ne[s]t), Nomadaria, ridefinisce il concetto di “casa senza radici” in chiave contemporanea: un’architettura leggera, simbolica e mediterranea che integra passato e presente, fondendo design, artigianato e paesaggio all’insegna del mutamento.


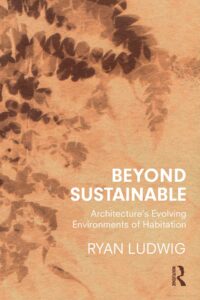
Il libro Beyond Sustainable
Il volume “Beyond Sustainable: Architecture’s Evolving Environments of Habitation” affronta in modo teorico questa idea di abitare “evolutivo”, superando l’idea di progetto univoco e finito.
Beyond Sustainable esplora il rapporto tra l’essere umano e gli ambienti costruiti in cui vive nell’Antropocene, un’epoca segnata da cambiamenti rapidi e imprevedibili. Il volume riconosce che l’umanità si trova ormai oltre la crisi climatica ed ecologica e non si concentra su come risolverla, ma su come affrontare e adattarsi ai cambiamenti irreversibili del sistema terrestre, ripensando il nostro modo di abitare il mondo. Attraverso l’analisi di progetti architettonici e artistici, insieme a riflessioni provenienti da filosofia, ecologia, biologia evolutiva, genetica, neurobiologia e psicologia, il libro propone una nuova visione dell’architettura: una disciplina capace di influenzare ciò che siamo, come viviamo, cosa proviamo e persino come evolviamo.
Il volume offre una panoramica completa di questa “riconcettualizzazione” dell’architettura, basata su una visione ecologica inclusiva e collaborativa.
L’autore, Ryan Ludwig, è architetto e docente alla University of Cincinnati, fondatore dello studio Ludwig-ArchOffice (L-AO), orientato a un design architettonico inclusivo e adattabile.
FAQ Progettare casa
Se immaginiamo la casa come un processo, come un “campo di possibilità”, si apre un orizzonte più sostenibile: spazi capaci di accogliere il cambiamento, che l’abitante può completare, adattare o trasformare nel tempo, senza dover demolire o ricominciare da capo. Ecco alcune delle domande più interessanti che gli utenti cercano online su questo tema.
Che cosa significa concepire la casa come uno “spazio vivo” e non come un “oggetto finito”?
Significa abbandonare l’idea della casa come prodotto statico, definitivo, per abbracciare una visione dinamica in cui l’abitazione può crescere, cambiare e adattarsi nel tempo. La casa diventa così un organismo in evoluzione, capace di accogliere nuovi bisogni, tecnologie e stili di vita.
In che modo questo approccio si collega ai principi della sostenibilità?
Una casa “viva” è più sostenibile perché evita sprechi di risorse: si progetta per durare e per trasformarsi, non per essere demolita o rifatta da zero. Materiali reversibili, sistemi modulari e soluzioni energetiche flessibili permettono di ridurre l’impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita dell’edificio.
Qual è il ruolo dell’architetto in questa nuova visione progettuale?
L’architetto non è più soltanto il “creatore” di una forma finita, ma diventa un “curatore” di processi. Accompagna il committente nel tempo, aiutandolo a immaginare come la casa possa evolversi, integrando modifiche e innovazioni senza tradire l’identità originaria del progetto.
Come reagiscono i committenti a un’idea di casa non completamente definita?
Molti inizialmente trovano difficile rinunciare alla sicurezza di una casa “confezionata”. Tuttavia, sempre più persone comprendono il valore di un’abitazione flessibile: un luogo che cresce con loro, che può cambiare funzione e forma senza perdere comfort e bellezza.
Ci sono esempi concreti di case progettate secondo questa filosofia?
Sì. Negli ultimi anni si moltiplicano progetti residenziali basati su principi di adattabilità e reversibilità: case modulari, spazi riconfigurabili, strutture leggere che possono essere ampliate o ridotte nel tempo. Questi esempi dimostrano che l’architettura può essere “viva” senza rinunciare alla qualità estetica e alla solidità costruttiva.
Foto in apertura: Ristrutturazione di una villa sui Castelli Romani, in chiave modernista e senza tempo. Progetto di STUDIOMAT. Credit ©Peter Molloy